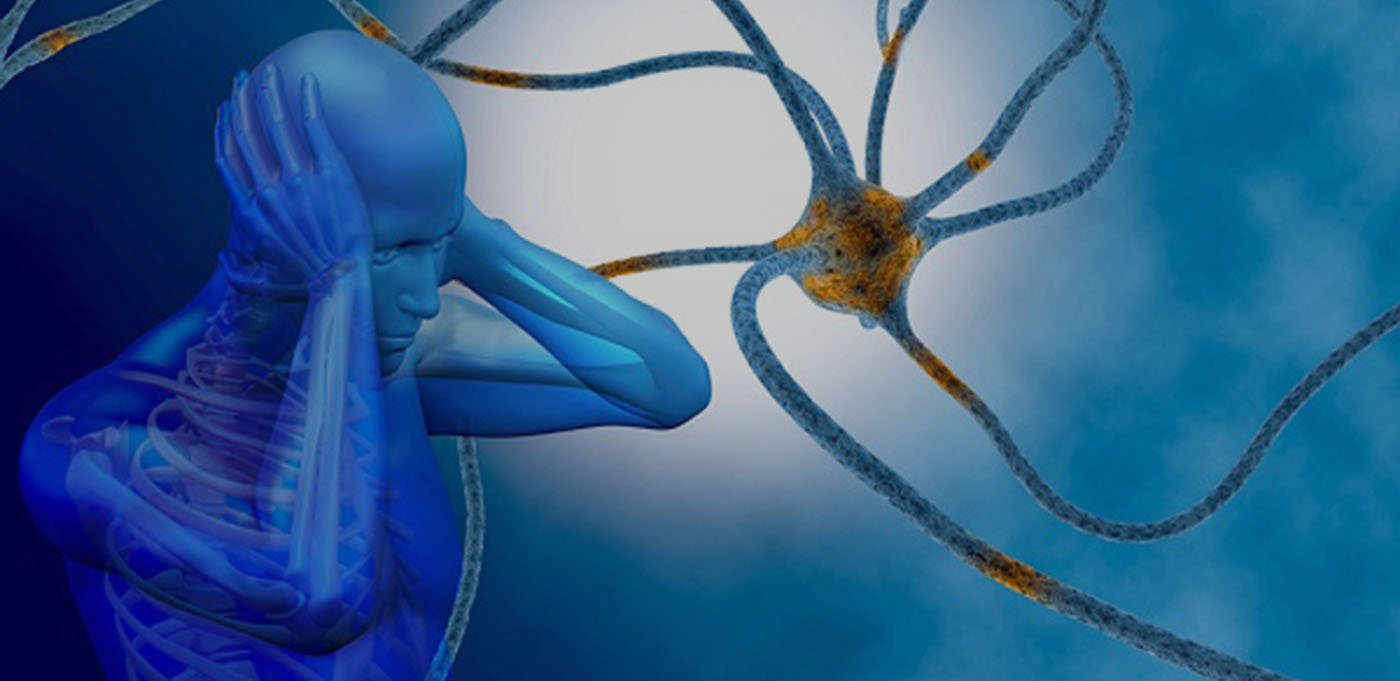La Malattia di Huntington è di origine genetica ed è causata dall’aumento del numero di nucleotidi in un gene del nostro DNA. Vi sono circa 20 mila geni nel DNA umano, ciascuno di loro composto da una serie di nucleotidi che racchiudono le istruzioni per costruire la corrispondente “proteina funzionale”. Ad esempio il gene per l’eritropoietina, presente nel nostro DNA, è composto da 498 nucleotidi. Nelle nostre cellule tale gene è responsabile della produzione della corrispondente proteina, cioè l’eritropoietina. Nella Malattia di Huntington, il gene che causa la malattia è chiamato IT15 e produce la proteina Huntingtina. Nella malattia, il gene è mutato e produce una proteina Huntingtina “mutata”, cioè leggermente diversa da quella “normale”. L’Huntingtina mutata provoca un progressivo danno al funzionamento e alla sopravvivenza di alcuni neuroni, con conseguenze sul piano motorio e comportamentale.
Le tappe fondamentali

La nascita di una comunità dedicata all’Huntington
Era il 1967. Dopo la perdita del marito Woody Guthrie, cantautore americano affetto dalla malattia, Marjorie Guthrie fondava la prima associazione laica a supporto dei malati di Huntington, chiamata “Committee to Combat Huntington’s Chorea”. In quegli anni la malattia era poco conosciuta e le persone e le famiglie molto isolate. Marjorie comprese che le famiglie non sapevano nemmeno di avere la malattia nella propria linea ereditaria in quanto spesso essa non veniva nemmeno correttamente diagnosticata, così com’era accaduto inizialmente anche a Woody. Marjorie Guthrie, affidandosi ai medici, capì che la malattia era ovunque nel mondo, anche se nascosta. Intuì che malati e famiglie, in alcuni casi, provavano un tale senso di vergogna da non riuscire a parlarne con nessuno, a causa di un terribile stigma e della discriminazione che li faceva sentire “diversi” invece che “semplicemente” uomini, donne, persone, con la malattia e bisognose di aiuto. Marjorie Guthrie non si arrese e comprese quanto fosse importante combattere questi pregiudizi sociali, anche grazie alla costruzione di una necessaria rete di solidarietà in cui malati, famiglie e medici potessero unirsi per sostenersi gli uni con gli altri.
Nel 1968 ebbe l’idea di pubblicare un’inserzione sul New York Times che recitava così “If you know anyone with Huntington’s Disease please call Marjorie Guthrie at VI8-0249” (“Se conosci qualcuno con la malattia di Huntington per favore chiama Marjorie Guthrie al VI8-0249”). Subito dopo quella pubblicazione iniziarono i primi contatti. Prima uno, poi dieci, poi moltissimi, più di quanto lei stessa potesse immaginare. Fu l’inizio di quello che oggi è diventata una grande comunità che intreccia studiosi, malati, medici e associazioni che lavorano insieme per costruire riferimenti per coloro che soffrono della Malattia di Huntington e per trovare una cura.
L’obiettivo immediato per Marjorie fu quello di creare “un’organizzazione forte” che assicurasse il più possibile l’accesso alle informazioni sulla malattia. Un’organizzazione che facesse sentire “incluso” chi tutti i giorni doveva affrontare, oltre al dolore della malattia, anche lo stigma, l’isolamento e l’esclusione che ne derivavano. Un’associazione che si impegnasse giorno dopo giorno per promuovere la ricerca su questa malattia ancora poco conosciuta e troppo stigmatizzata. Era nato il “Committee to Combat Huntington’s Chorea”.

La scoperta del gene responsabile della Malattia di Huntington
Era il 1993. Dopo decenni di studio, ecco la scoperta che, finalmente, identificava il gene responsabile della malattia. Ad esso si arrivò grazie agli sforzi di scienziati e medici coordinati dalla genetista americana Nancy Wexler, anche lei a rischio di Huntington: sia sua madre, sia i suoi tre zii avevano infatti sviluppato la malattia. Spinta dal voler sapere il più possibile di questa malattia poco conosciuta che permeava la sua famiglia, a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, Nancy venne a conoscenza del fatto che in Venezuela, nei villaggi intorno al lago Maracaibo, vi era una elevatissima incidenza di malati di Huntington. Per questo radunò e portò in Venezuela i migliori genetisti europei e americani. L’esito della discriminazione sociale, di strutture familiari allargate, di un alto tasso di natalità e della povertà si era tradotto nella crescita di interi villaggi in cui moltissimi abitanti erano accomunati dalla stessa malattia.
Il gruppo di ricercatori si concentrò sul trovare il gene responsabile della malattia partendo dal sangue dei malati venezuelani. In quegli anni, infatti, le conoscenze sul genoma erano ancora molto rudimentali, e dunque era estremamente difficile identificare e localizzare un gene raro: era necessario poter analizzare un’ampia genealogia di discendenti, come gli emarginati abitanti dei villaggi venezuelani. È quindi grazie, letteralmente, al “loro sangue” generosamente donato alla ricerca e a questo sforzo collettivo dei ricercatori che oggi, nel nostro più fortunato Occidente, abbiamo il riconoscimento della malattia, la possibilità di un test genetico, farmaci sintomatici e speriamo di arrivare presto a un trattamento che blocchi o ritardi la progressione della malattia.
Da quando il gene è stato identificato, molto si è scoperto sui meccanismi patogenici alla base della malattia. Attualmente sono in corso alcune sperimentazioni cliniche per valutare l’efficacia di nuove strategie terapeutiche.
La prima sperimentazione clinica specifica sulla Malattia di Huntington
È il 2015. Si avvia la prima sperimentazione clinica specifica per la malattia di Huntington, esito di molti anni di studio su modelli sperimentali e del coinvolgimento delle prime aziende farmaceutiche che cominciano ad occuparsi della cura dell’Huntington. È la prima volta che un impegno di questa entità viene messo in campo per una malattia rara come l’Huntington. ROCHE e IONIS si alleano per promuovere una nuova ed innovativa sperimentazione, basata sull’idea di “silenziare” il gene malato. Il farmaco è un “oligonucleotide antisenso”, una molecola che “silenzia” specificatamente il gene Huntingtina malato bloccandone la tossicità. La fase I della sperimentazione clinica, atta a valutare sicurezza, effetti collaterali, dosi e tempistiche di trattamento procede così bene che ROCHE ottiene il via libera per procedere direttamente alla fase III, allo scopo di valutare l’efficacia del trattamento su un più ampio numero di pazienti.
Nel maggio 2021 tuttavia, la sperimentazione del farmaco chiamato Tominersen viene interrotta poiché, dopo un’attenta e costante valutazione dei dati della sperimentazione, il rapporto rischi-benefici viene giudicato “sfavorevole” da valutatori esperti e indipendenti. Il coinvolgimento di valutatori esterni di provata competenza e indipendenza nel monitoraggio delle sperimentazioni cliniche in corso costituisce uno dei più importanti progressi della medicina moderna e ha in primo luogo lo scopo di tutelare i malati in corso di trattamento. La delusione legata all’interruzione della sperimentazione con Tominersen è stata forte, ma nel tempo ad essa si è affiancata la consapevolezza che anche una sperimentazione fallita è utile alla ricerca, nel momento in cui si comprendono le cause di quel fallimento. Nel frattempo, molte altre aziende e ricercatori hanno unito le loro forze alla lotta contro la malattia di Huntington e lungo la strada del silenziamento genico. La stessa ROCHE, dopo quasi due anni di attenta valutazione dei dati clinici ottenuti con Tominersen, intraprenderà a breve un nuovo trial clinico utilizzando una diversa somministrazione dello stesso farmaco.